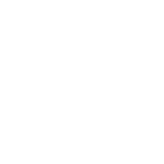Descrizione
Storia e Descrizione
Il Monumento fu inaugurato nel 1922 per commemorare i soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale con una cerimonia solenne. L’opera è una colonna dorica di calcare dolomitico di Gonnesa, realizzata da Giuseppe Maria Sartorio (1854-1822), scultore di fama, molto attivo in Sardegna in quel periodo. A tale artista si devono ben 65 monumenti nel Cimitero di Iglesias, le statue dei Santi Pietro e Paolo a Cuglieri, il monumento ai Caduti in Piazzetta Martiri a Cagliari, quello a Vittorio Emanuele II in Piazza Italia a Sassari e altri innumerevoli opere. Numerose le sue opere presso il Cimitero Monumentale di Bonaria a Cagliari, le quali hanno contribuito a renderlo celebre non solo in Sardegna.
Alla base del monumento sono presenti tutti i nomi dei Serramannesi caduti o dispersi nelle Guerre di Indipendenza e nei conflitti mondiali. Ogni 4 Novembre hanno luogo nelle vicinanze le celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e della commemorazione dei caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona d’alloro.
L’inaugurazione del Monumento: la testimonianza di Vico Mossa
L’architetto Vico Mossa (1914-2003), nel suo libro I Cabilli, fornisce una testimonianza storica su ciò che accadde il 4 Novembre 1822, giorno dell’inaugurazione: Frequentavo da qualche settimana la quinta classe quando, il quattro novembre, si celebrò una gran festa, la più grande che ricordi della mia fanciullezza. Più grande ancora del concorso ginnastico. Fu inaugurato in piazza il monumento ai Caduti in guerra (ben sessantadue), opera dello scultore Giuseppe Sartorio. (A me, quel monumento non andava tanto giù per via dell’aquila reggente una bandiera, che somigliava specie nel crepuscolo a un cane accucciato), la sottoscrizione era stata unanime e all’organizzazione della festa partecipò tutta la popolazione: all’addobbo delle strade, specie quelle dove doveva passare il corteo, per preparare il palco e per allestire il grande banchetto, essendo assai numerosi le autorità e gli invitati giunti dalla città e dai paesi. Sfilarono tutti uniti però incolonnati secondo le proprie idee o preferenze: gli atleti della Società Ginnastica, in divisa azzurra, attillatissima, con alla testa la fanfara, i fascisti in camicia nera col gagliardetto nero, gli autonomisti (quelli che avevano resistito alle lusinghe dei fascisti), in camicia cenerina, con la bandiera dei Quattro Mori, le scolaresche con le bandierine di carta [...] le varie associazioni religiose, il Circolo di lettura, la Società operaia, tutti con bandiera, e pure con bandiera “i cattolici” che per la prima volta apparvero così numerosi preceduti dai giovani esploratoni. Dopo il corteo, i lunghi discorsi e lo scoprimento del monumento, che era stato avvolto in una enorme bandiera tricolore, dopo l’omaggio alle vedove e agli orfani in gramaglie, cominciò il carosello degli incolonnati. Ogni gruppo per proprio conto: i fascisti passavano e ripassavano, salutando il monumento col saluto romano. Altrettanto facevano i sardisti; ma salutavano inarcando il braccio destro verso sinistra, e rispettivi capi davano il “front’a destr” e il ’front’a sinistr”, e così ripeterono di notte, quando ebbe termine lo sparo dei fuochi d’artificio”.