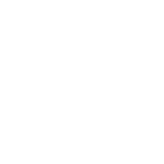Descrizione
I Monti Granatici in Sardegna
L’istituzione dei Monti Granatici si diffuse in modo capillare in Sardegna nella seconda metà del XVI secolo al fine di sostenere l’agricoltura locale attraverso l’anticipazione della semente ai coltivatori e la conservazione, per conto della comunità, della riserva di grano indispensabile per la semina. Basavano la loro sussistenza sul lavoro gratuito dei contadini i quali dedicavano un numero variabile di giornate lavorative (le cosiddette roadie) alla coltivazione delle terre comuni. Le roadie si svolgevano, previo beneplacito delle autorità ecclesiastiche locali, la domenica dopo la prima messa, su un terreno comunale o baronale. Dal regolamento promulgato dal Vicerè Lodovico Hallot des Hayes nel 1767 si evince l’organizzazione gerarchica dei Monti Granatici sardi. Il livello più alto era occupato dalla Giunta Generale, con sede a Cagliari e composta dal Reggente la Reale Cancelleria, dalle prime tre voci degli Stamenti, da tre alti ecclesiastici e da un Segretario nominato dal Sovrano. Distribuite sul territorio erano invece le Giunte Diocesane, insediate in ogni Diocesi e composte dal Vescovo, da un Canonico, dal Sindaco e dal Censore.
Ogni comunità aveva invece la sua Giunta Locale, composta dal Canonico Prebendato, dall’Ufficiale di Giustizia e dal Censore (la cui funzione consisteva nello scegliere i terreni da lavorare ed assistere ai lavori di semina, mietitura e trebbiatura). Le Giunte Locali avevano il compito di fissare la dote granatica (la quantità di grano necessaria al corretto funzionamento del Monte) tenendo conto dei terreni coltivabili e delle richieste degli agricoltori. Inoltre nominavano il Depositario, un funzionario la cui carica durava tre anni e che aveva il compito, di fondamentale importanza, di custodire e distribuire il grano.
Il Monte Granatico di Serramanna
Fu istituito ufficialmente nel 1761. Non è certo che sin dal momento della sua istituzione fosse dotato di una sede vera e propria: si suppone che il grano venisse inizialmente conservato in locali privati. L’attuale struttura venne sicuramente costruita intorno ai primi anni del XIX secolo. Nel celebre Dizionario Geografico-storico, di Vittorio Angius e Goffredo Casalis, pubblicato nella seconda metà del sec. XIX, viene così descritto: “il fondo granatico del monte di soccorso ascende a più di 2500 ettolitri (starelli 5000) e prospera bene amministrato sotto la vigilanza del vicario [il Parroco] che è capo dell’Amministrazione. Si è ingrandito il locale mercé le assidue cure ed i suggerimenti dello stesso vicario, che con tutta sollecitudine studia al vantaggio del suo popolo”. L’edificio, in parte proprietà del Banco di Sardegna, è costruito con mattoni di terra cruda (làdiri). Si affaccia sia in Via Montegranatico sia in Via Giulio Cesare. Dopo aver ospitato la Biblioteca Comunale è stato restaurato e destinato ad usi socio-culturali. Il piano terra, dotato di un pavimento in cotto, ospita convegni ed incontri culturali di vario genere. Degna di nota risulta essere la fattura del solaio di interpiano: è l’unico esempio serramannese di struttura realizzata con travi in ferro a doppio T e volte in mattoni pieni. Il secondo piano è utilizzato per mostre ed esposizioni. Il solaio è realizzato con capriate, orditura e tavolato in legno e tegole tipo coppo sardo.